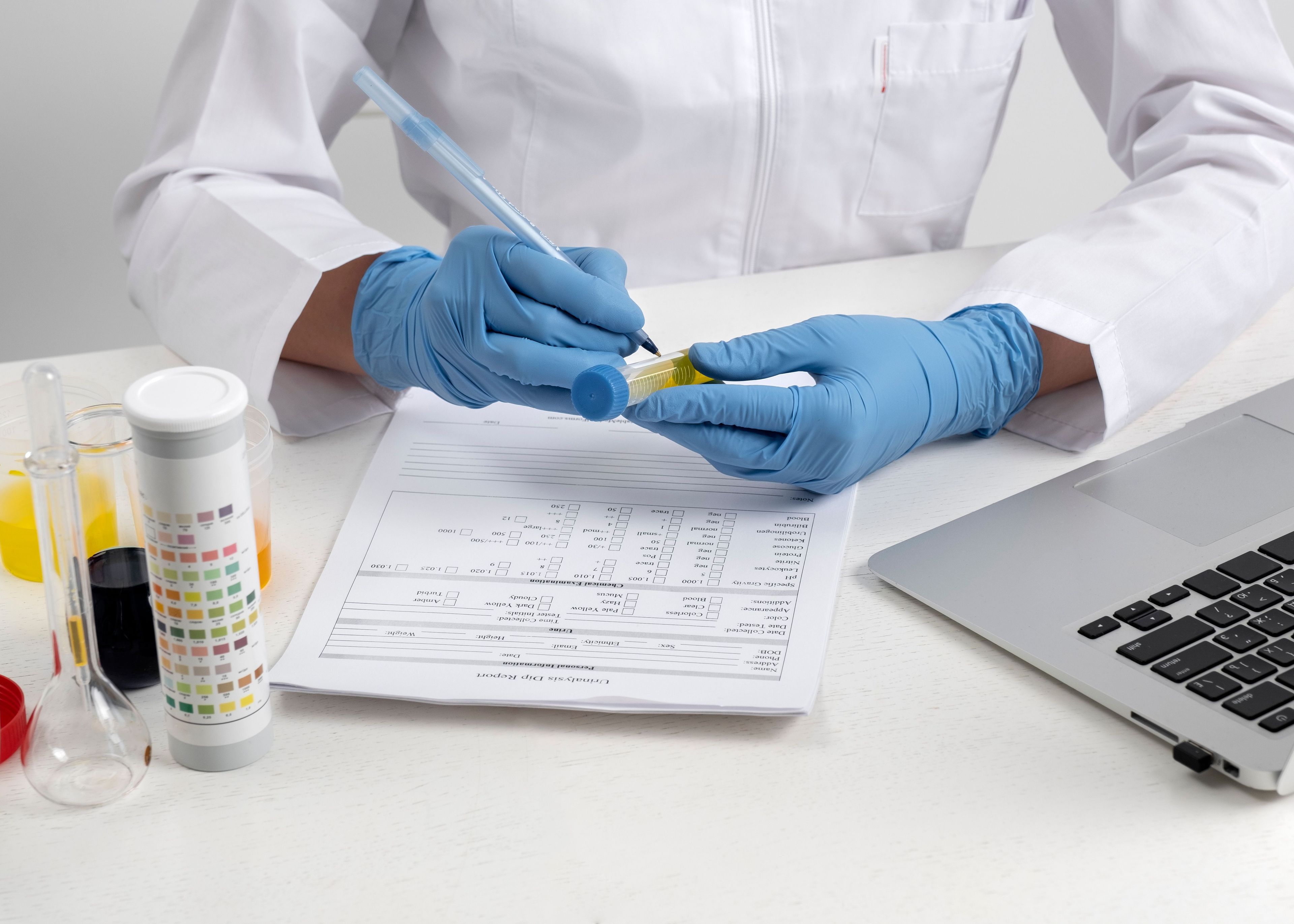Malattie esantematiche

- Cosa sono le malattie esantematiche?
- Eziologia: virus e batteri come principali responsabili
- Manifestazioni cliniche: dalla febbre all’esantema
- Le principali malattie esantematiche
- Diagnosi e approccio clinico
- Trattamento e gestione
- Prevenzione: il ruolo dei vaccini
- Cosa sono le malattie esantematiche?
Le malattie esantematiche sono un gruppo eterogeneo di patologie accomunate dalla presenza di eruzioni cutanee, spesso accompagnate da altri sintomi sistemici come febbre, malessere generale e ingrossamento dei linfonodi. Gli esantemi possono variare nella forma, nel colore e nella distribuzione, passando da macchie rosse puntiformi (maculopapulari) a bolle piene di liquido (vescicolari). Generalmente, queste patologie sono causate da infezioni virali o batteriche. Nei bambini, le malattie esantematiche classiche comprendono morbillo, varicella, rosolia, scarlattina, quinta malattia e sesta malattia. Anche infezioni meno comuni, come quelle causate da virus enterici o arbovirus, possono dare origine a esantemi.
- Eziologia: virus e batteri come principali responsabili
La maggior parte delle malattie esantematiche ha un’origine infettiva. I principali agenti patogeni coinvolti sono:
- Virus: sono i responsabili della maggioranza dei casi. Tra questi si annoverano il morbillo (causato dal virus della famiglia Paramyxoviridae), la rosolia (Rubivirus), la varicella (virus varicella-zoster) e i virus erpetici (HHV-6 e HHV-7) associati alla sesta malattia
- Batteri: sebbene sia meno frequente, alcune malattie esantematiche sono causate da batteri come nel caso della scarlattina, dovuta al Streptococcus pyogenes, un batterio beta-emolitico di gruppo A.
Questi patogeni si trasmettono prevalentemente per via aerea, attraverso droplet o contatto diretto con le secrezioni di persone infette. In alcuni casi, come per la varicella, la trasmissione può avvenire anche attraverso il contatto con il liquido contenuto nelle vescicole cutanee.
- Manifestazioni cliniche: dalla febbre all’esantema
Le manifestazioni cliniche delle malattie esantematiche variano a seconda dell’agente eziologico, ma generalmente seguono un andamento simile:
- Periodo di incubazione: è il lasso di tempo che intercorre tra il contagio e la comparsa dei primi sintomi. Può variare da pochi giorni (ad esempio per la scarlattina) a settimane (come nel morbillo)
- Sintomi prodromici: prima della comparsa dell’esantema, molti pazienti sviluppano febbre, mal di gola, congestione nasale o altri sintomi sistemici
- Comparsa dell’esantema: l’eruzione cutanea si manifesta tipicamente in modo simmetrico, iniziando spesso dal viso o dal tronco e diffondendosi progressivamente al resto del corpo.
- Le principali malattie esantematiche
Le principali malattie esantematiche sono:
- Morbillo: il morbillo è una malattia altamente contagiosa causata da un virus della famiglia Paramyxoviridae. È caratterizzato da febbre alta, tosse, congiuntivite e macchie di Koplik (piccole lesioni biancastre nella mucosa orale), seguite da un esantema maculopapulare che inizia dal volto e si diffonde verso il basso. Le complicanze, come polmonite ed encefalite, sono rare ma potenzialmente gravi
- Varicella: la varicella è causata dal virus varicella-zoster (VZV) ed è caratterizzata da un esantema vescicolare che evolve rapidamente in croste. È più comune nei bambini, ma negli adulti può essere più severa e complicarsi con polmonite o infezioni batteriche sovrapposte
- Rosolia: la rosolia, causata dal Rubivirus, è generalmente lieve nei bambini, con febbre ed un esantema maculopapulare. Tuttavia è estremamente pericolosa durante la gravidanza, poiché può causare la sindrome della rosolia congenita, con gravi malformazioni fetali
- Scarlattina: causata da Streptococcus pyogenes, la scarlattina si presenta con febbre, mal di gola ed un esantema caratterizzato da una texture ruvida (a "carta vetrata"). La lingua può assumere un aspetto a "fragola"
- Quinta malattia: nota anche come eritema infettivo, è causata dal parvovirus B19. Si manifesta con un eritema tipico a forma di "guance schiaffeggiate" ed un rash diffuso al tronco e agli arti
- Sesta malattia: associata al virus HHV-6 o HHV-7, colpisce prevalentemente i bambini sotto i due anni. Dopo alcuni giorni di febbre alta, compare un esantema maculopapulare improvviso, soprattutto sul tronco.
- Diagnosi e approccio clinico
La diagnosi delle malattie esantematiche si basa principalmente sull’anamnesi e sull’esame obiettivo. L’osservazione delle caratteristiche dell’esantema, in associazione ai sintomi sistemici, è cruciale per distinguere le diverse patologie.
Un aspetto fondamentale nell’approccio diagnostico è distinguere le malattie esantematiche da altre condizioni dermatologiche o sistemiche che possono manifestarsi con rash cutanei. Tra queste:
- Reazioni allergiche: spesso causano rash diffusi, ma mancano di febbre e altri sintomi sistemici
- Malattie autoimmuni: come il lupus eritematoso sistemico, possono presentarsi con esantemi, ma si accompagnano a segni e sintomi cronici, come dolori articolari persistenti
- Infezioni non esantematiche: ad esempio, infezioni meningococciche o setticemie possono causare petecchie o rash maculari.
Nei casi dubbi o per confermare una diagnosi, possono essere utilizzati esami di laboratorio quali:
- Test sierologici per rilevare anticorpi specifici contro il patogeno sospettato
- Esami colturali o molecolari (es. PCR) per identificare virus o batteri.
- Trattamento e gestione
Il trattamento delle malattie esantematiche varia in base alla causa:
- Terapie sintomatiche: febbre e prurito possono essere trattati con antipiretici (paracetamolo) e antistaminici
- Antivirali: nei casi di varicella severa o herpes zoster, possono essere utilizzati antivirali specifici come l’aciclovir
- Antibiotici: sono indicati solo per malattie di origine batterica, come la scarlattina, o per complicanze sovrapposte.
Nei casi più gravi, può essere necessario il ricovero ospedaliero per monitorare complicazioni sistemiche.
- Prevenzione: il ruolo dei vaccini
La prevenzione delle malattie esantematiche si basa principalmente sull’adozione di programmi di vaccinazione. Vaccini altamente efficaci sono disponibili per morbillo, rosolia e varicella, spesso somministrati come parte della combinazione MPR (Morbillo, Parotite, Rosolia)
Il vaccino MPR è solitamente somministrato in due dosi:
- Prima dose: tra i 12 e i 15 mesi di età
- Seconda dose: tra i 4 e i 6 anni, oppure in concomitanza con il richiamo di altri vaccini prima dell’ingresso scolastico.
Per gli adulti che non sono mai stati vaccinati o non hanno avuto una documentazione affidabile della loro immunizzazione, è possibile somministrare il vaccino in età avanzata.
Il vaccino viene iniettato per via sottocutanea o intramuscolare, preferibilmente nel braccio (muscolo deltoide) o nella coscia nei bambini piccoli. Il vaccino MPR si è dimostrato altamente efficace, in particolare:
- Morbillo: una dose conferisce una protezione del 93%, che aumenta al 97% con due dosi
- Parotite: l’efficacia è variabile tra l’88% e il 95%, in base al ceppo virale circolante
- Rosolia: una dose garantisce una protezione superiore al 97%.
Le evidenze suggeriscono che l’immunità indotta dal vaccino MPR è di lunga durata, probabilmente per tutta la vita. Raramente, alcune persone vaccinate possono perdere l’immunità nel tempo, ma ciò è molto meno comune rispetto al rischio di infezione naturale.
Il vaccino MPR inoltre è considerato sicuro per la maggior parte della popolazione. Tuttavia, come tutti i farmaci, può causare effetti collaterali, generalmente lievi e temporanei:
- Reazioni comuni: dolore o arrossamento nel sito di iniezione, febbre leggera, rash cutaneo transitorio
- Effetti avversi rari: febbre alta con convulsioni febbrili (1 caso su 3.000 vaccinazioni) o reazioni allergiche gravi (anafilassi, 1 caso su un milione di dosi somministrate).
Non vi è alcuna evidenza scientifica a supporto di un legame tra il vaccino MPR e disturbi come l’autismo, nonostante le teorie errate diffuse in passato. Numerosi studi epidemiologici di alta qualità hanno confutato tale correlazione.
Quando una proporzione sufficiente della popolazione è vaccinata, la trasmissione del virus si riduce, proteggendo anche chi non può essere vaccinato (ad esempio neonati o soggetti immunocompromessi). L’obiettivo dell’immunità di gregge è particolarmente rilevante per il morbillo, che richiede una copertura vaccinale del 95% per prevenire epidemie. Grazie a questo vaccino si è ridotta drasticamente l’incidenza del morbillo nei Paesi con alti tassi di copertura vaccinale.